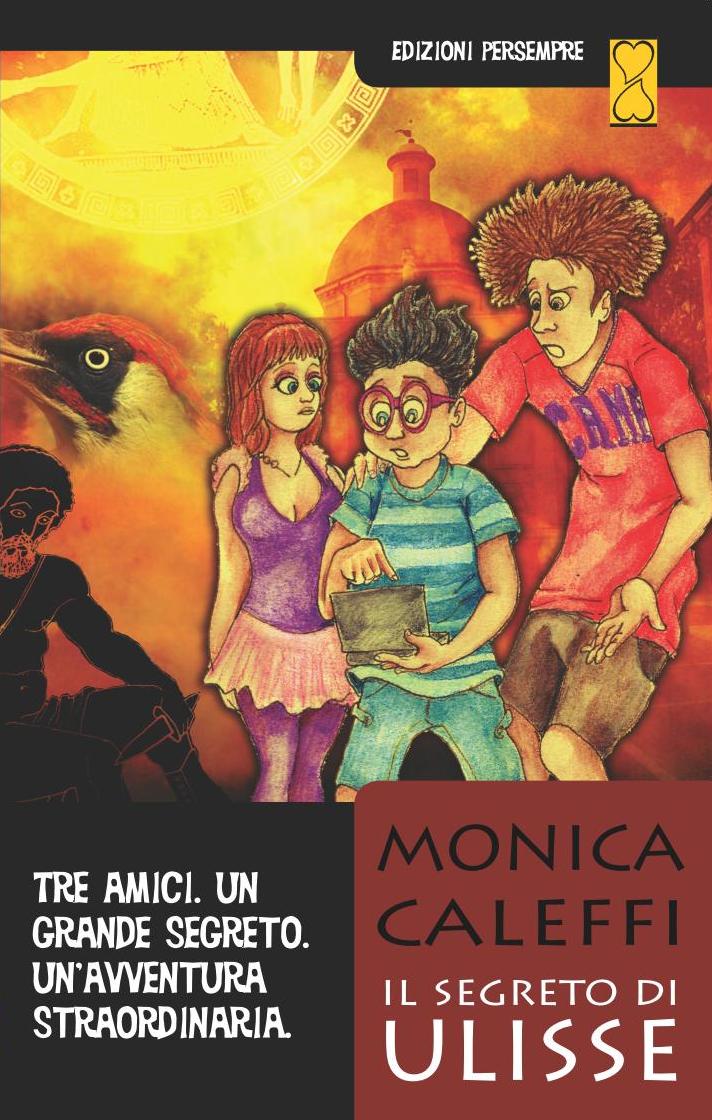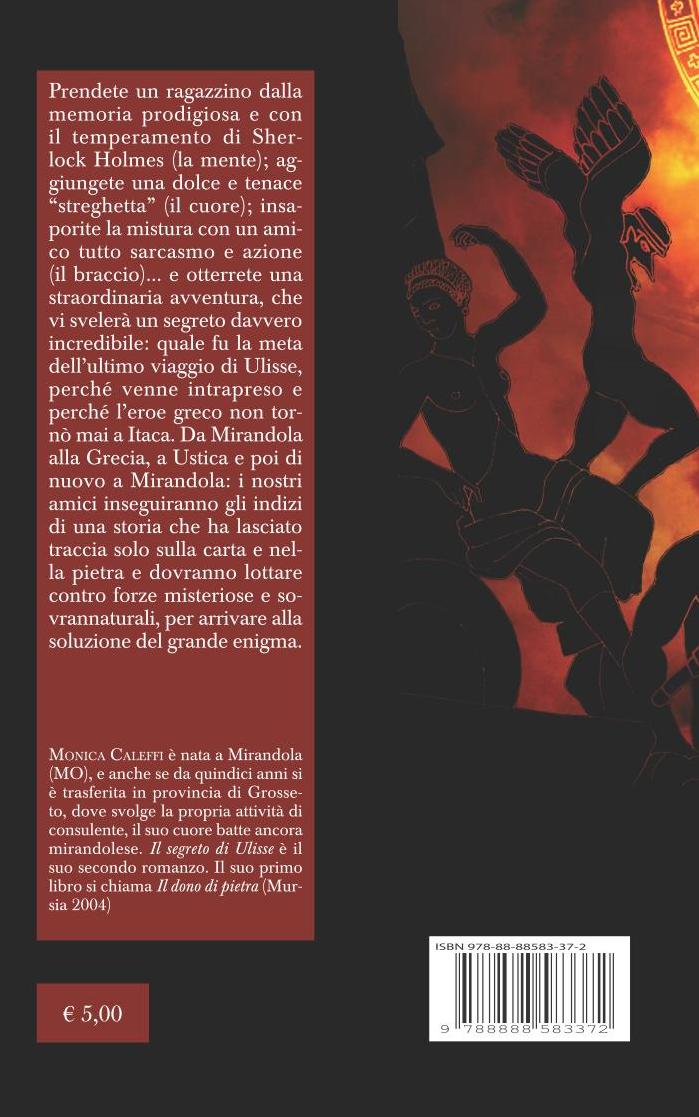Capitolo 27
I tre ragazzi corsero come pazzi verso la casa di Brando, mentre già un sacco di gente assonnata sbirciava dalle finestre socchiuse per vedere cosa fosse quel trambusto.
Alle sei e un quarto erano al sicuro, chiusi a chiave nella stanza di Picchio, trafelati, impolverati, impauriti e tremanti. Ma anche e soprattutto sconvolti dall’esperienza vissuta e dalla curiosità divorante di osservare attentamente il pugnale e di scoprire cosa fosse quel fagotto maleodorante che Picchio aveva trovato tra le pietre del campanile e che ora giaceva sulla scrivania assieme all’arma.
Decisero saggiamente di darsi una calmata e una bella ripulita, facendo a turno una doccia nel bagno privato di Brando. Il ragazzo mise a disposizione magliette e jeans puliti. Il momento era cruciale, avevano quasi paura a toccare quei due oggetti.
All’improvviso furono presi da una strana angoscia, una oscura paura, come se non si sentissero degni di scoperchiare quella sorta di vaso di Pandora,1) di stracciare il velo del tempo e guardare oltre i secoli. La curiosità li aveva divorati per mesi, li aveva fatti andare in giro come trottole per trovare indizi, notizie, risposte. E ora esitavano.
Fecero la doccia, presero caffè e biscotti, Marcello scartò due chewing-gum e se li cacciò in bocca, Martina telefonò ai genitori, il tutto sempre occhieggiando alla scrivania, girandoci intorno, sbirciando e distogliendo lo sguardo.
«Adesso! Dobbiamo farlo adesso, dobbiamo guardare il pugnale, aprire quell’involto puzzolente che ammorba la stanza, Marcello! Dobbiamo sapere. Adesso!»
Picchio si accinse a impugnare l’arma antica per osservarla da vicino e ripulirla dalla ruggine dei secoli. Come la ebbe tra le mani, tuttavia, una scossa lo fece tremare in tutto il corpo. Il ragazzo impallidì improvvisamente, perse quasi l’equilibrio. Fece cadere a terra il pugnale, non poteva più sopportare quella sensazione angosciante di malessere fisico e mentale.
«Picchio, che ti succede, che hai?» gridò Martina.
«Marcello, Martina, non ce la faccio a tenerlo in mano: non so dirvi perché, ma provo una sensazione devastante, un’angoscia indicibile e un vero e proprio malore fisico. Raccoglietelo voi, se potete, ripulitelo dalla ruggine, mentre io mi sdraio un attimo sul letto. La testa mi gira come una trottola. Non capisco perché: quando l’ho estratto dalle pietre del campanile non ho provato niente di simile. Ma ora…»
Marcello, con cautela, raccattò dal pavimento il pugnale, aspettandosi di provare chissà che. Invece a lui l’arma non fece alcun effetto. La ripulì delicatamente ma a fondo: ora il freddo acciaio mandava bagliori quasi minacciosi.
«Picchio, guarda, qui c’è scritto qualcosa, lungo la lama sono incise delle parole, ma non riesco bene a distinguerle, sono piccolissime.»
Brando, che nel frattempo aveva ripreso colore, si alzò improvvisamente dal letto, rovistò in un cassetto e ne trasse una grossa lente di ingrandimento.
«Posa il pugnale sulla scrivania, Marcello. Presto, devo leggere quelle parole!»
Senza toccarla, Brando osservò Parma con attenzione usando la lente. Una sottilissima scritta correva lungo tutta la lunghezza della lama, ancora affilata:
Pugio signum erat. Hic bulla est,Johannis posuit. Non diducenda est, a progenie forsan, sui capitis periculo.
«Allora, Picchio, forza, riesci a leggere la scritta? Cosa dice? Vuoi farci morire di curiosità?» Marcello non stava più nella pelle e aveva pronunciato quella richiesta con tono pressante, mentre Martina si torceva convulsamente una ciocca di capelli senza riuscire neanche a proferire parola, gli occhi sgranati, le guance pallidissime.
«“Il pugnale era il segno. Qui si trova il medaglione, ve lo pose Giovanni. Esso non deve essere aperto, se non forse da un discendente, e con grave pericolo per la sua vita.” La scritta dice così, più o meno» rispose Brando in un sussurro.
«Allora quel fagotto schifoso e puzzolente contiene davvero il medaglione? E cosa aspettiamo ad aprirlo? il fagotto, dico. Aprire il medaglione sarà tutta un’altra faccenda, a quanto pare…» sbottò di rimando Marcello, sempre più eccitato, ma anche preoccupato.
«Sì» rispose Brando, lo sguardo assorto e assente, «ma fatelo voi, per favore. Togliete quella cosa orrida e buttatela via, bruciatela, fatene quello che volete. Non sopporto più quell’odore.» Il ragazzo pareva in trance,2)
le parole gli uscivano in un soffio, in un bisbiglio, come se gli mancasse il respiro.
«Certo, sempre a noi toccano i compiti ingrati! Dai, Martina, diamoci da fare con quella schifezza.»
I due ragazzi, torcendo il naso, riuscirono a svolgere l’involto, fragile e ammuffito, che si rivelò essere un drappo di pelle marcita dai secoli. Lo bruciarono in un cestino di metallo, dal quale sprigionò un fumo denso e acre, che li costrinse a spalancare tutte le finestre.
Finalmente il medaglione apparve ai loro occhi attoniti in tutto il suo splendore.
L’oro brillava come se fosse stato appena forgiato, splendeva come una stella nel buio della notte. La forma era proprio quella raffigurata sul vaso di Itaca, nei basso- rilievi della Grotta delle Ninfe e nella tomba di Canente alla Tesa: grossi anelli d’oro concatenati e un medaglione rotondo di considerevole spessore, completamente liscio sulla faccia inferiore e finemente cesellato e smaltato su quella superiore. L’incisione recava, come in una sorta di cammeo, l’immagine di un volto di donna, bellissimo
e pauroso allo stesso tempo.
Le labbra carnose e invitanti sorridevano, ma lo sguardo rimaneva freddo e distante. I capelli neri, raccolti in lunghe trecce come mosse dal vento e appena trattenute sulla fronte da una fascia, le conferivano un aspetto quasi selvaggio.
I ragazzi non potevano staccare gli occhi da quel volto, in cui fascino femminile, seduzione e malvagità si fondevano in un tutt’uno sconvolgente.
Non poteva essere che lei, Circe, l’incantatrice.
«E adesso che si fa?» chiese Martina, scossa dal realismo dell’immagine, così diversa da quella dell’amata Canente.
Marcello alzò le spalle, come a dire “e chi lo sa?” e guardò Picchio, che conservava quell’espressione assorta e lontana.
Dopo un silenzio carico di tensione che parve interminabile, Brando alzò lo sguardo, prese in mano il medaglione e fissando negli occhi gli amici disse in un soffio: «Sono io. Il discendente di Pico sono io. La mia famiglia ci ha sempre scherzato su questa cosa, ma è vera. L’ho controllata anni fa, ricostruendo il nostro albero genealogico. Nel corso dei secoli il nome “Picus” è diventato “Piccinini”, ma sono io la progenie di Pico. Io solo posso aprire il medaglione, se ciò che dice la scritta sul pugnale è la verità».
Gli amici lo guardarono attoniti.
«L’hai sempre saputo e non ce l’hai mai detto…» lo accusò Martina.
«Non credevo che la faccenda avesse alcuna attinenza con la nostra avventura, ve lo giuro. Fino a ora non ci avevo mai pensato. Mi è venuta in mente solo adesso, leggendo la scritta.»
«Ma la frase dice: “con grave pericolo per la sua vita”. Brando, sei sicuro di volerlo fare? di volere davvero aprire quel medaglione? Non sappiamo affatto cosa potrebbe succederti. Ti prego, non farlo. Lo abbiamo trovato, siamo stati bravi, sei stato bravo, hai capito tutto, hai ricostruito tutto, hai trovato tutte le prove. Ora basta. Portiamolo al museo cittadino assieme al pugnale, prendiamoci una bella sgridata per il mezzo crollo del campanile e dimentichiamoci tutto. Ti prego. Ho paura.»
Martina aveva parlato con calore, il timore traspariva dalle sue parole e dalla sua voce tremante. Marcello, per una volta, non aprì bocca.
«Non posso, ragazzi. Devo aprirlo, lo sento. È un destino ineluttabile, che forse mi aspetta dal giorno in cui sono nato. E poi magari invece è tutta una fandonia, non c’è niente da aprire, niente da vedere, niente di cui avere paura. Ma lo devo sapere.»
Così dicendo, Brando rigirò più volte tra le mani il medaglione, ma dapprima non gli parve che vi fosse alcuna possibilità di aprirlo. Sembrava semplicemente un’unica grande moneta con due facce.
Allora riprese la lente e in breve si accorse che in realtà una sottilissima fessura correva tutto intorno al bordo del disco d’oro, come se fosse fatto di due metà perfettamente combacianti.
Ebbe improvvisamente un’idea: afferrò il pugnale, che stranamente stavolta non gli fece alcun effetto, e accostò alla fessura del medaglione la lama affilata e sottile come un rasoio.
In quel preciso istante accadde l’incredibile.
Un canto angoscioso si levò nell’aria. Di nuovo la voce di Canente attraversò le loro orecchie e le loro menti con la violenza di un affondo di spada, mentre la sua immagine evanescente, fluttuando nell’aria, si materializzò all’improvviso, con le stesse fattezze con cui i ragazzi l’avevano veduta raffigurata nella sua tomba.
Al suo fianco apparve istantaneamente un’altra figura, altrettanto sconvolgente: un uomo in tunica e sandali, il profilo aquilino. Indubbiamente Ulisse.
Il suo sguardo era eloquente, implorava Picchio di non aprire il gioiello, supplicava e comandava allo stesso tempo, scuotendo vigorosamente il capo ricciuto.
Ma un’improvvisa, agghiacciante risata femminile dissolse i fantasmi e riecheggiò nella stanza nel momento esatto in cui Brando, affondando la lama del pugnale nella fessura, riuscì a dividere le due metà del medaglione.
Quel riso sinistro di vittoria continuò a ferire i loro timpani mentre Brando, che tremava in tutto il corpo come una foglia, guardò all’interno del gioiello.
Ne ricadde improvvisamente una ciocca di lunghissimi capelli neri intrecciati, che si dissolsero come per magia, finendo in polvere sul pavimento. Ma c’era anche una scritta incomprensibile, incisa nell’oro all’interno del monile.
La risata cessò, ma la stessa voce agghiacciante, seducente eppure cattiva, carica di rancore e di passione a un tempo, in modo del tutto comprensibile proferì queste parole di maledizione:
Breve è il respiro mio per i tuoi baci amari, Ulisse, eppur Itaca tu invochi, e la triste Penelope, quando Morfeo ti coglie e lasse son le membra.
Ma di me, che sono Circe la maga,
giammai svanir dovrà il ricordo
dal salmastro cuore del guerriero errante.
Né altri lidi, né donne, ninfe o dee, né battaglie, né secoli e sventure la memoria cancellar dovranno.
Acciò ti pongo al collo quest’aureo medaglione,
d’amor e di magia forgiato,
delle scritte parole segreto scrigno.
Memoria prodigiosa avrà chi lo possiede.
Che alle amate italiche mie genti in qualche modo esso votato resti dopo l’ultimo tuo viaggio in Acheronte.
Ma alcun, se non del casto Picchio il segno rechi, aprir potrà dopo di te lo scrigno, ed anzi tempo all’Ade oscuro discenderà.
1) Pandora fu la prima donna del genere umano, creata da Zeus. Egli le donò, con il divieto di aprirlo, un vaso, nel quale stavano rinchiusi tutti i mali del mondo, il dolore, la vecchiaia, la morte. Ma ella fu sopraffatta dalla curiosità e, aprendolo, diede loro vita ed essi dilagorono sulla terra. Nel vaso, troppo tardi richiuso da Pandora, rimase solo la Speranza, unica cosa bella che Zeus vi aveva messo.
2) Trance, stato ipnotico.
Epilogo
Era autunno inoltrato e già da un po’ le scuole avevano riaperto i battenti. Come sempre, alla fine delle lezioni, gli studenti si ritrovavano sul sagrato della chiesa di San Francesco a scambiare le ultime chiacchiere prima di tornare a casa. L’accesso alla torre campanaria era stato murato per sempre. Le giornate si erano accorciate e quel pomeriggio il sole già volgeva al tramonto, infuocando le facciate della chiesa e delle vecchie abitazioni che si affacciavano sulla piazzetta.
Brando e Martina, tenendosi per mano teneramente, raggiunsero Marcello che li stava aspettando.
«Ehi, piccioncini, come va? E un po’ che non vi vedo in giro dopo la scuola! Brando, stai bene?»
L’iniziale ironia nel tono del ragazzo si era tramutata in preoccupazione.
«Tutto bene, Marcello, non ti angosciare, e, soprattutto, non angosciare me. Non sono ancora in punto di morte!» rispose Picchio e scherzosamente tirò fuori da sotto il maglione il medaglione di Circe e lo fece dondolare davanti al naso dell’amico.
«Ma nascondi quel coso, perdinci, non vorrai che tutti lo vedano!»
Brando sospirò e disse: «Be’, la nostra avventura è finita. Ulisse tenne fede alla promessa fatta a Picus e trovò sua moglie e suo figlio. Non aprì mai il gioiello donatogli da Circe e lo regalò a Lainos, non sapendo di essere l’inconsapevole latore di una maledizione. In un qualche modo il gioiello si è tramandato di generazione in generazione fino al nostro Giovanni Pico. Egli lo aprì, senza dubbio, ed ebbe una vita breve ma intensa: la sua memoria era prodigiosa, i suoi scritti vengono ancora ricordati. Ma la maledizione di Circe lo colpì. Comprendendone la portata, sperimentandola sulla propria pelle, prima di morire decise di nascondere il medaglione maledetto. E noi lo abbiamo trovato, nonostante Ulisse, Picus e Canente abbiano fatto di tutto per impedircelo. Mi dispiace contraddirti, Martina cara. Tu pensavi che Canente volesse aiutarci e per un po’ l’ho creduto anch’io. Ma poi ho dovuto ricredermi davanti all’evidenza dei fatti. Ora sono convinto che tutti i tentativi di dissuasione durante il nostro percorso fossero opera loro, o, sicuramente, di almeno uno di loro. Ricordate? Il picchio, posato sul pozzo della scuola, che sembrava voler dire “no” scuotendo il capo, la macchina che mi ha investito senza farmi troppo male, il vaso scomparso a Ithàki, la strana marea e quel canto angosciante nella Grotta delle Ninfe e via discorrendo, fino all’ultima apparizione mentre avevo in mano il monile nella mia stanza.
«Gli “aiuti”, invece, che abbiamo ricevuto durante la nostra avventura credo siano venuti solo ed esclusivamente dalla maga. Circe voleva che trovassimo il medaglione per perpetuare la maledizione, lei ci ha fatto avere quel biglietto gratuito per il viaggio, lei ci ha fatto trovare ogni traccia che ci ha condotti fino alla verità.
«Io sono un discendente di Pico e per questo ho potuto aprire il medaglione, con tutte le conseguenze che me ne deriveranno. Ma sono felice di averlo fatto. Non ho la memoria prodigiosa menzionata nella maledizione, anche se qualcuno mi ritiene un mezzo genio, e soprattutto non so, e non voglio sapere, quanto sarà lunga o breve la mia vita. Ora sono qui e questo basta…»
Martina sorrise, guardando negli occhi il ragazzo bruttino, l’amico d’infanzia che all’improvviso aveva catturato il suo cuore. Poi, rivolta a Marcello, disse: «Il nostro, ehm… Piccinini sta benone, e poi adesso ha la sua streghina a tenerlo d’occhio costantemente. Chissà che in due non si riesca a sciogliere l’incantesimo, ad annullare per sempre la maledizione di Circe. Come disse Virgilio, Omnia vincit amor, “L’amore vince su tutto”! Forse è proprio questa la formula magica!».
«Va be’, sarà come dite voi. Ricordatevi, quando sarà il momento del viaggio di nozze, di andare da Callidoro a raccontargli la fine della storia. E, per sicurezza, non mettete al mondo dei bambini, per carità!»